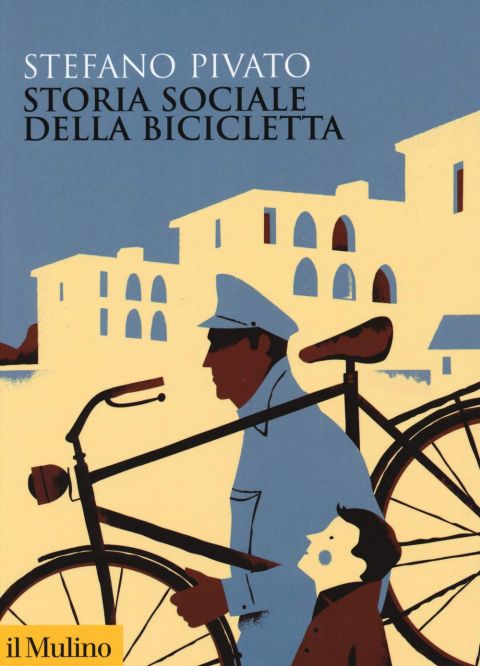"Stirpe e vergogna" di Michela Marzano
di Mario Avagliano
Gli italiani i conti con la propria storia recente, e in particolare con il fascismo, che abbagliò con la sua luce sinistra la maggior parte della popolazione, ancora non li hanno fatti. Nel nostro Paese non c’è stata un’assunzione di responsabilità di ciò che è accaduto dopo la conquista del potere da parte di Benito Mussolini e il varo delle leggi fascistissime – soppressione delle libertà, caccia agli oppositori, leggi razziali, crimini di guerra - con un processo Norimberga o un processo Tokyo, come avvenuto in Germania e in Giappone. Di più, dopo la liberazione l’Italia fu la prima nazione europea a lanciare un’amnistia generalizzata, già nel giugno 1946, a firma del leader dei comunisti Palmiro Togliatti, all’epoca ministro della Giustizia, anche se frutto di un accordo con il democristiano Alcide De Gasperi, capo del governo.
La conseguenza di questa fretta di voltar pagina è che molti italiani che si erano sporcati le mani con il fascismo, ne hanno bellamente approfittato, celando sotto il tappeto il proprio scomodo passato. Una rimozione collettiva, in qualche modo avallata dallo Stato. E così, scavando nelle storie familiari, può capitare di scoprire, consultando un certificato di battesimo, come accade a Michela Marzano, che il vero nome completo del padre non è solo Ferruccio, bensì Ferruccio Michele Arturo Vittorio Benito. Sì, proprio Benito, come Mussolini. E quando gli chiede il perché, lui risponde con nonchalance che il nonno Arturo era fascista. La scrittrice, ex deputata del Pd, rimane traumatizzata e comincia a porsi degli interrogativi inquietanti. A chiedersi se la propria autorappresentazione di donna di sinistra, proveniente da una famiglia democratica e progressista (il padre è da sempre socialista), non presenti qualche falla.
È il tema dell’intenso romanzo Stirpe e vergogna (pubblicato da Rizzoli), in cui Michela Marzano, con uno stile incalzante e avvincente, compie un’indagine retrospettiva sul nonno magistrato, Arturo Marzano, nato vicino a Lecce nel 1897, sottotenente sul Carso nel 1917. E ricordando che nella casa dove ha trascorso l’infanzia a Campi Salentina passava sempre davanti a una grande teca piena di medaglie, bottoni, nastri e fascette, la cerca nella casa dei genitori a Roma. Vi rinviene la tessera del nonno di iscrizione al movimento di Mussolini risalente addirittura al maggio 1919, poco dopo la fondazione dei Fasci di combattimento, e l’attestazione che ha partecipato alla marcia del 28 ottobre 1922. Tutti lo sapevano eccetto lei.
Nonostante la sorpresa e lo sgomento interiore, Michela Marzano non sfugge al passato e anzi testardamente si avventura a frugare nei cassetti, nei documenti e negli album fotografici di famiglia, divorando nel frattempo libri, articoli di giornale e film o documentari su quegli anni, per ricostruire la parabola umana, politica e sentimentale di Arturo. Dal matrimonio con la nonna Rosa, da cui avrà due figli, all’appassionata relazione extraconiugale con Bice (recuperando il carteggio tra i due amanti), dalla sua adesione al fascismo alla sua partecipazione attiva, in qualità di magistrato, alla commissione di Lecce che stabiliva quali italiani mandare al confino per attività antifascista o semplicemente per una barzelletta sul duce o un insulto, fino al processo per l’epurazione nel 1944, ai silenzi successivi su quella storia, alla sua elezione come deputato del partito monarchico nel 1953 e alla sua morte nel 1976, quando la nipote aveva appena sei anni.
Un’inchiesta intima e familiare, quasi sotto forma di diario, che sfiora anche altre pieghe oscure della vita dell’autrice, come il suo difficile rapporto con la maternità e con il padre Ferruccio. E che però, superando gli inevitabili ostacoli del viaggio interiore (il 25 aprile del 2020 Michela confessa di vivere per la prima volta «il giorno della Liberazione con imbarazzo»), diventa anche un’inchiesta pubblica sulle colpe di quasi tutti gli italiani, visto che gli antifascisti furono un’esigua, seppur coraggiosa, minoranza. Come fu possibile che un intero popolo s’innamorasse del duce? E che anche un uomo capace di tenerezza e di «cuore grande» come il nonno Arturo non abbia capito il male del fascismo? La tesi di Marzano è che Il riscatto, come è intitolata l’ultima parte del romanzo, si realizzi solo con il passaggio dallo stato di amnesia del dopoguerra alla presa di coscienza del carattere dittatoriale del fascismo e dell’ampio consenso degli italiani al duce. L’Italia sarà mai in grado di farlo fino in fondo, senza sconti di sorta e senza infingimenti?
(Blog Mario Avagliano, 2021)
- Pubblicato in Articoli