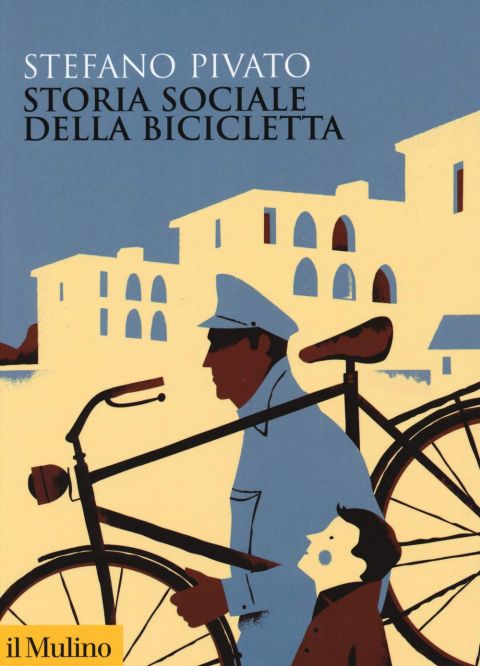di Mario Avagliano e Marco Palmieri
Tra i crimini perpetrati dai nazisti nel corso della seconda guerra mondiale ce ne è uno che spesso viene dimenticato, ma che è costato la vita a migliaia di uomini e donne, tra lavoratori coatti, deportati civili e internati militari. Durante gli allarmi aerei, i carcerieri nazisti obbligavano i deportati e gli internati a non abbandonare il posto di lavoro, per non interrompere l’attività produttiva, oppure a non uscire dalle baracche dei campi di concentramento, che non recavano le necessarie insegne e segnalazioni per essere riconosciuti dai bombardieri. In questo modo atroce, specie negli ultimi due anni di guerra, persero la vita migliaia di persone. Solo tra gli Internati Militari Italiani, secondo una stima verosimile di Claudio Sommaruga, i bombardamenti aerei causarono circa 2.700 vittime, alle quali devono essere aggiunti migliaia di altri morti, in numero impossibile da definire con esattezza, tra “schiavi”, deportati civili e prigionieri di guerra italiani e di altre nazionalità.
Malgrado cifre così rilevanti, questo tema non è stato ancora esplorato a fondo e con sistematicità in sede di ricerca storica. Nel corso degli ultimi anni, però, il tema della massiccia campagna aerea scatenata dagli angloamericani per piegare la Germania di Hitler, prima e durante l’attacco terrestre, sta tornando al centro dell’attenzione e dell’interesse di studiosi e ricercatori. Tali studi hanno il merito di aver spostato, per la prima volta, il focus dell’analisi e della ricostruzione degli avvenimenti, dagli aspetti più propriamente militari, strategici e tecnici, a quelli relativi all’impatto sulla popolazione civile tedesca e al prezzo da essa pagato in termini di vite umane. Un prezzo senza dubbio elevatissimo, ma nell’ambito del quale non può essere dimenticato quello pagato anche da militari e civili che si trovarono in Germania per effetto della grande deportazione di uomini e donne attuata dai nazisti e che persero la vita in seguito ai comportamenti criminali dei loro carcerieri.
La campagna aerea sulla Germania.
La decisione di sottoporre la Germania ad un intensa campagna di bombardamenti aerei venne presa nel corso dell’incontro tra Churchill e Stalin nell’agosto del 1942. Tale decisione rappresentò un capitolo saliente della lunga polemica relativa all’apertura del cosiddetto “secondo fronte”: in risposta alle continue richieste di uno sbarco angloamericano nel nord Europa da parte di Stalin, infatti, in quell’incontro Churchill rispose con la promessa di uno sbarco in Africa Settentrionale entro la fine dell’anno e, appunto, un massiccio programma di bombardamenti aerei sul suolo tedesco, in vista dello sbarco in Europa rinviato all’anno successivo. Obiettivo dichiarato della campagna aerea fu da un lato di fiaccare la Germania di Hitler dal punto di vista materiale, colpendo infrastrutture, apparati industriali e produttivi, dall’altro di piegare il morale di civili e militari, nella speranza di spingere la popolazione a far mancare il proprio sostegno e consenso al regime nazista.
I primi bombardamenti inglesi di una certa entità sulla Germania risalgono alla primavera del 1940, in un momento particolarmente critico per l’Inghilterra, dopo l’occupazione tedesca della Norvegia e l’invasione della Francia. Churchill del resto era personalmente convinto che una intensa campagna di bombardamenti pesanti sulla Germania potesse rappresentare un contributo decisivo alla vittoria finale contro Hitler anche perché, in assenza di un forte esercito di terra, l’Inghilterra aveva avviato la preparazione alla guerra aerea contro la potenza continentale tedesca fin dalla metà degli anni Trenta. Fino a tutto il 1942, però, per la guerra aerea furono anni interlocutori, perché mancavano ancora quei miglioramenti organizzativi e operativi che sarebbero stati messi in atto più tardi dalla Royal Air Force, ma soprattutto perché la potenza aerea degli Alleati aumentò in maniera esponenziale solo quando gli Usa schierarono in Europa i loro bombardieri, nel corso del 1942. A questo punto la RAF si dedicò prevalentemente al bombardamento notturno delle zone industriali, mentre l’aviazione americana prese in consegna fabbriche, vie di comunicazioni, stazioni ferroviarie e depositi di carburante, colpendo durante il giorno.
Il 1943 rappresentò un momento di svolta nella strategia della guerra aerea, perché Churchill e Roosevelt si accordarono per dare priorità alla campagna aerea, in attesa dell’apertura del “secondo fronte” terrestre, ulteriormente rinviata al 1944. Verso la fine del 1943, inoltre, divenne chiaro che finché l’aviazione alleata non avesse sconfitto la Luftwaffe, lo sbarco nel nord della Francia e la successiva avanzata verso il cuore della Germania avrebbe presentato ancora troppi rischi. Così, in seguito all’intensificarsi dell’azione aerea, nel corso del 1944 l’equilibrio tra le due forze aeree cominciò a volgere in favore degli Alleati, quando i tedeschi non riuscirono più a rimpiazzare le perdite con la produzione di nuovi velivoli a causa dei danni che i bombardamenti stessi avevano provocavano all’industria aeronautica e a quella petrolifera.
Da questo momento in poi la guerra aerea angloamericana funzionò in piena efficienza, concentrandosi pesantemente su tutte le strutture chiave dell’economia tedesca. Nel corso del 1944 venne sganciato sulla Germania la maggior parte del tonnellaggio complessivo di bombe di tutta la guerra. Anche perché, conquistato il dominio dell’aria, i bombardieri inglesi e americani poterono agire pressoché indisturbati e senza incontrare più alcuna resistenza, mentre i caccia e i cacciabombardieri, non più impegnati in compiti di scorta, poterono dedicarsi agli attacchi di precisione contro il sistema dei trasporti a terra. Quando gli angloamericani sbarcarono in Normandia, la Germania poteva contare solo su qualche centinaio di aerei funzionanti, contro gli oltre 12 mila alleati, e il suo potenziale bellico, produttivo e logistico era stato messo a dura prova da mesi e mesi di bombardamenti quotidiani.
Le ricerche recenti
Con i mezzi disponibili all’epoca, la precisione dei bombardamenti aerei era molto approssimativa e fin dai primi “esperimenti”, nelle fasi iniziali della guerra, ci si rese conto che la loro efficacia nel colpire obiettivi precisi era decisamente ridotta, specie di notte quando venivano effettuate la gran parte delle missioni per sfuggire agli sbarramenti e alla reazione della contraerea. Questo motivo indusse gli inglesi a non disdegnare la tattica dei bombardamenti a tappeto, che finirono inevitabilmente per colpire anche le città e i sobborghi urbani a ridosso delle zone industriali e delle grandi vie di comunicazione. Il prezzo pagato dai civili tedeschi fu senza dubbio alto e drammatico, con circa mezzo milione di uomini, donne e bambini rimasti uccisi sotto gli attacchi aerei e la distruzione di intere città.
Sulla campagna aerea degli angloamericani, due ricerche tradotte e pubblicate anche in italiano hanno recentemente riacceso l’attenzione di opinione pubblica e studiosi, sottolineandone e mettendone pienamente a fuoco il suo drammatico impatto sulla popolazione civile. La prima, condotta da Jörg Friedrich (La Germania Bombardata, Mondatori 2004), traccia una dettagliata mappa geografica e cronologica delle azioni dell'aviazione inglese e americana sul territorio tedesco, analizzando le armi impiegate, le strategie attuate, le zone più colpite, la dislocazione dei rifugi, le reazioni della collettività, che cosa si riuscì a salvare e cosa andò distrutto. L’altra è opera di Anthony C. Grayling (Tra le città morte. I bombardamenti sulle città tedesche: una necessità o un crimine?, Longanesi 2006) e offre un quadro altrettanto dettagliato dei luoghi colpiti e delle vittime provocate dalle esplosioni e dagli incendi.
Senza volersi addentrare nella questione “militare” riproposta in alcune di queste pagine – se i bombardamenti così massicci e indiscriminati ebbero un ruolo più o meno determinante nel decidere le sorti del conflitto o se una parte di queste vite umane avrebbero potuto esser risparmiate – sta di fatto che anche in questa fase di rinnovato interesse storico, il crimine nel crimine perpetrato dai nazisti contro deportati e internati rischia di passare sotto silenzio. Di tale crimine, del resto, praticamente non c’è traccia alcuna in quei pochi documenti “ufficiali” che oggi sono reperibili negli archivi italiani e tedeschi. Così come è particolarmente improbabile stilare un “bilancio” preciso delle vittime, distinguendo questa “voce” all’interno della tragica contabilità più generale delle vittime della barbarie nazista. Un contributo decisivo allo sforzo di ricostruzione storica, però, lo possono dare senza dubbio le memorie e i diari dell’epoca. In essi, le sirene degli allarmi aerei e le esplosioni vicine e lontane, sono annotazioni praticamente quotidiane. E con esse anche la paura, e la morte: “Una bomba mi è cascata a 50 metri da mè – scrive l’internato militare Giuseppe Marchi nel suo diario, riferendosi al bombardamento di Hagen del 2 dicembre 1944 – 70 dei miei compagni morti e le baracche tutte in fiamme, io sono rimasto coi pantaloni, e pastrano tutta l’altra roba mi era bruciata. Tremavo dalla paura, nel vedere quel macello, una gamba da una parte e un braccio da quell’altra, non ero capace di lasciarmelo passare” (Due veronesi nei lager, Istituto veronese per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, Cierre edizioni 2001).
Un crimine nel crimine nazista
Un così alto tributo di vite umane pagato dagli internati e dai deportati civili trova spiegazione innanzitutto nel fatto che i lager dove essi erano rinchiusi non avevano alcuna segnalazione della croce rossa riconoscibile dall’alto e soprattutto erano ubicati a poca distanza dagli impianti industriali, dove i prigionieri venivano impiagati, o dai nodi stradali e ferroviari. I lager, inoltre, non avevano rifugi antiaerei e quando suonavano gli allarmi i prigionieri erano costretti a rimanere chiusi nelle baracche di legno, sotto la minaccia armata dei loro carcerieri. Frequenti furono anche i casi di uccisioni e ferimenti – senza alcuna possibilità di soccorso fino al cessato allarme – di chi non rispettava l’ordine.
I deportati e gli internati avviati al lavoro coatto, invece, spesso erano costretti a rimanere sul posto di lavoro per non interrompere l’attività produttiva anche sotto la minaccia dei bombardamenti. Una volta che i bombardieri avevano sganciato il loro carico esplosivo, invece, questi “schiavi” venivano immediatamente impegnati nello sgombero delle macerie e nelle operazioni di recupero e sepoltura delle vittime, senza alcuna protezione sanitaria. Anche laddove i rifugi esistevano, infine, erano quasi sempre riservati ai tedeschi, mentre gli IMI e i deportati potevano usufruire tutt’al più di piccole fosse con qualche asse di legno che in realtà non fornivano alcun riparo né dalle schegge, né dagli incendi. Per approfondire il tema nella maniera più dettagliata possibile, dunque, una strada importante da seguire è quella della raccolta, dell’analisi, della verifica e dell’incrocio delle informazioni contenute nelle memorie e nei diari dell’epoca, come quelli che stiamo utilizzando per scrivere una storia “dal vivo” e raccontata dai diretti protagonisti, della deportazione civile e dell’internamento militare.
("Rassegna", ANRP, n. 3-4, Anno XXIX, marzo-aprile 2007)