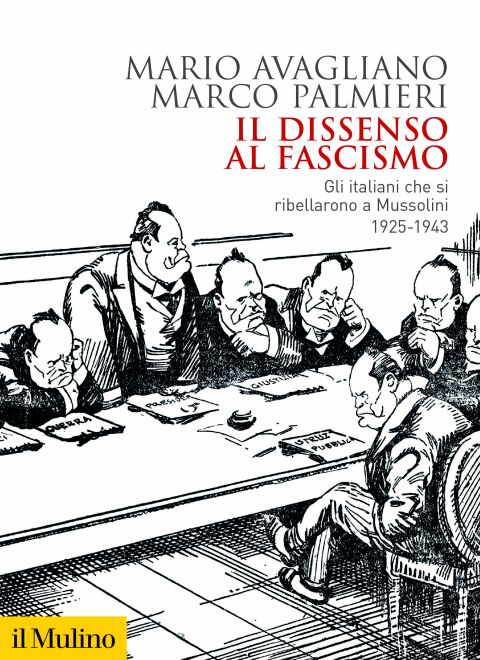Fascismo, non è stato un gioco
di Diego Gabutti
Banalizzare (come si dice) il fascismo è stato sempre uno sport molto praticato in Italia. Mussolini «buonuomo», gli antifascisti «in villeggiatura» alle isole, i gerarchi in pantofole, la dittatura mite e generosa, la bonifica delle paludi, la Treccani, giusto un po' d'antisemitismo (ma indulgente, mica come a Berlino). Non si capiva, in fondo, perché gli oppositori del regime andassero esuli all'estero. Potevano restarsene tranquillamente anche qui, pacifici, indisturbati, persino un po' riveriti.
Coccolati da Primato, cari ai frondisti come Leo Longanesi e Indro Montanelli, e in fondo simpatici anche allo stesso Dux, gli antifascisti avrebbero potuto essere l'ala democratica (diciamo così) del regime se soltanto fossero stati meno cocciuti. Un po' come oggi, sotto la stella cometa del governo meloniano, quando il neofascismo («onore al Msi», commemora la seconda carica dello Stato) è stato trasformato dal voto popolare (il 26% del 55% dell'elettorato) nell'ala littoria della democrazia.
Per lo più il fascismo è caramellato e farcito d'uvetta da storici e memorialisti, che ridacchiano, beffeggianti ma ammirati, del Duce a cavallo che brandisce la Spada dell'Islam, del Duce aviatore e sciatore, del Duce che si molleggia con i pugni sui fianchi nella gabbia Non è bello né sano che oggi, dopo ottant'anni di racconto storico assolutorio e banalizzante, ci tocchi anche un governo banalizzatore che con il fascismo storico c'entrerà magari poco, anzi niente, ma che del neofascismo non è solo una parodia ma l'erede diretto, come Articolo 1 e Sinistra italiana del comunismo del leone, del Duce armato di falce e a torso nudo che partecipa alla battaglia del grano, del Duce giocatore di bocce.
Raccontato così, deriso e rimpianto insieme nei memoir dei giornalisti e dei diplomatici più compromessi, filtrato attraverso le mattane dei legionari fiumani, tutto tele futuriste e telefoni bianchi, il fascismo diventa uno scherzo e gli oppositori degli zucconi che non capiscono la barzelletta. Ci sono libri scanzonati sui rapporti al Duce dell'Ovra, la polizia politica. Si possono leggere libri leggeri e goliardici sulle imprese erotiche di Mascellone nella Sala del Mappamondo. Gli si accreditano opinioni antinaziste ((pando c'era tutt'al più dell'invidia per la bella presenza delle SS, alte e marziali, dalla divisa impeccabile, mentre a lui toccavano militi «brevilinei», sgualciti e pelandroni). Passa per libertario, addirittura per «auto-mormoratore», se non per antifascista occulto: l'idea generale è che il fascismo non sia colpa sua ma degl'italiani, «ingovernabili», «indisciplinati», eterni bambini. Straparlano così, da ottant'anni in qua, intere biblioteche.
Rare se non rarissime le eccezioni: tra i titoli recenti Il caso Mussolini (Neri Pozza 2022) di Maurizio Serra, la biografia di Giovanni Gentile (Il filosofo in camicia nera, Mondadori 2021) di Mimmo Franzinelli, il Mussolini capobanda (Mondadori, 2022) di Aldo Cazzullo e questo Il dissenso al fascismo di Mario Avagliano e Marco Palmieri, storici accurati delle zone in ombra dell'Italia nella prima metà del secolo. Mentre non c'è storia del fascismo, dei suoi Guf, delle sue disfatte militari, dei suoi slogan ridicoli, dei suoi ras, del suo Minculpop, delle sue Opere Balilla, dei suoi gerarchi, dei suoi architetti e trasvolatori, delle sue donne fertili, dei suoi squadristi in orbace o in doppiopetto che non abbia al centro qualche grand'uomo a pancia in dentro e petto in fuori, Avagliano e Palmieri in tutti i loro libri si sono invece sempre occupati di cose che contano e di persone vere.
Negli anni, hanno raccontato la storia delle leggi razziali e dell'antisemitismo fascista, dello sbarco alleato, dei soldati al fronte, della resistenza disarmata dei militari italiani internati nei lager tedeschi per non essersi arruolati nei ranghi di Salò, dei primi anni del secondo dopoguerra, della resistenza allo stalinismo nel 1948. Qui, con Il dissenso al fascismo, si occupano dei dissidenti — gli antifascisti che, tra la proclamazione della dittatura nel 1925 e la caduta del fascismo nel 1943, cercarono d'opporsi al regime e ne furono perseguitati. A fermarli non fu il «consenso» di cui godeva il fascismo, come raccontano gli storici compiacenti, ma il terrore scatenato dal regime contro l'opposizione in qualsiasi forma, dal partito liberale a quello socialcomunista, dai Testimoni di Geova ai boy-scout.
Tutt'altro che caramellosa, niente canditi, zero uvetta, la storia della repressione negli anni del fascismo è la storia d'un regime criminale, assassino, feroce. Non è vero che Hitler e Stalin fossero peggio di Mussolini soltanto perché fecero peggio di lui. Mussolini ha fatto quel che ha potuto coni mezzi e il materiale umano che aveva. Se solo ne avesse avuto i mezzi, il vantaggio e l'occasione, non avrebbe certo indietreggiato di fronte al genocidio, come infatti dimostrarono le leggi razziali del 1938 che gettarono in pasto ai cannibali migliaia d'ebrei. Qualunque cosa se ne legga nei libri così spiritosi di Leo Longanesi, nelle Storie d'Italia di Montanelli o nelle biografie di Filippo Tommaso Marinetti, di Giuseppe Bottai e di Berto Ricci, un antisemita rabbioso che Montanelli definiva «un anarchico» e «un idealista», il fascismo non fu affatto uno scherzo né un intermezzo piacevole: eravamo ragazzi, c'era l'avventura dell'impero, giovinezza, giovinezza.
A decine di migliaia d'italiani (molti dei quali lasciarono clandestinamente il paese poiché anche l'espatrio era diventato un reato, com'era reato raccontare barzellette sull'Uomo della Provvidenza o criticare per una qualsiasi ragione il regime) non era sembrato divertente farsi purgare e randellare dalla feccia della società nazionale. Decine di migliaia d'italiani finirono in galera, al confino, in manicomio, stipati nelle isole che la stampa internazionale descriveva realisticamente come «Siberia e Cayenna italiane». Ci furono centinaia di suicidi, la maggioranza dei quali soltanto tra virgolette: malnutriti, torturati con le tecniche più efferate, talvolta persino violentati (come raccontano Avagliano e Palmieri) dalle stesse guardie carcerarie, gl'internati antifascisti morivano come mosche, assassinati senza che i loro aguzzini fossero chiamati a risponderne.
Avagliano e Palmieri scavano in una vasta costellazione di piccole storie che finiscono male, malissimo, bene, mai benissimo. Storie d'avvocati, d'operai, di calzolai, d'ingegneri espulsi dall'ordine, di studenti e insegnanti, di sacerdoti, di donne e uomini che il fascismo ha imprigionato, torturato, oltraggiato, ucciso. «No, non è terrore, è appena rigore», spiegò Mussolini alla Camera il 26 maggio 1927. «Terrorismo? Nemmeno; è igiene sociale, profilassi nazionale, si levano dalla circolazione questi individui come un medico toglie dalla circolazione un infetto» Erano discorsi da teppista, i soli che gli si addicessero. Stalin e Hitler dicevano esattamente le stesse cose.
Come ci ricordano Avagliano e Palmieri, è di questo che si parla quando si parla di fascismo. Sul dissenso e la resistenza al fascismo è stata fondata la repubblica, che per quanto imperfetta è sempre meglio di qualunque regime. Non è bello né sano che oggi, dopo ottant'anni di racconto storico assolutorio e banalizzante, ci tocchi anche un governo banalizzatore che con il fascismo storico c'entrerà magari poco, anzi niente, ma che del neofascismo non è solo una parodia ma l'erede diretto, come Articolo 1 e Sinistra italiana del comunismo. C'era Mario Draghi a Palazzo Chigi e adesso guardateci.
(Italia Oggi, 31 dicembre 2022)
- Pubblicato in Articoli